
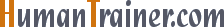
HT: La Psicologia per Professionisti
Il rapporto fraterno: tra legame e conflitto
 SIPEA - Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie
SIPEA - Società Italiana di Psicologia Educazione e ArtiterapieWorkshop residenziale di Arteterapia: 'Attraverso il tempo' - Roma
 ISCRA - Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e Relazionale
ISCRA - Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e RelazionaleCorso di formazione: 'Coordinazione Genitoriale sistemica' - Online
 IPSE - Istituto Psicologico Europeo
IPSE - Istituto Psicologico EuropeoCorso di formazione specialistica in Psicomotricità con l'adulto - Varese

Il rapporto fraterno: tra legame e conflitto
- Il legame fraterno e l'inevitabile ambivalenza
- Le difficoltà del rapporto e il ruolo genitoriale
- Rivalità tra fratelli e unione fraterna
Articolo: 'Il rapporto fraterno: tra legame e conflitto'
- INDICE: Il rapporto fraterno: tra legame e conflitto
- Introduzione
- Il legame fraterno e l'ambivalenza inevitabile
- L'arrivo dello straniero: i rapporti tra fratello maggiore e minore
- E il secondogenito?
- La rivalità fraterna: aspetti psicodinamici
- Non solo nemici...
- Bibliografia
- Altre letture su HT
Introduzione
I connotati di affetto e sostegno che caratterizzano il legame fraterno sono in gran parte dovuti alla comunanza biologica, educativa ed
esperienziale che ne coinvolge i membri. L'indissolubilità dell'unione fraterna, sancita da una dimensione prettamente genetica, trova
un precipuo fattore di consolidamento nella condivisione di scenari evolutivi ed educativi che ne caratterizza l'esistenza soprattutto durante
la prima fase della vita. Ma anche a seguito dello svincolo familiare, l'interiorizzazione di questa unione arcaica svolge una funzione
perpetuante del legame, favorendone la continuità temporale a dispetto del mutare dei singoli contesti esistenziali.
Data questa premessa, pur basilare, sarebbe tuttavia errato pensare al legame fraterno come a un rapporto estraneo a conflitti e divergenze.
Sono in realtà numerosi i fattori in grado di condizionarne l'evoluzione, rendendone la gestione difficoltosa, mutevole, frastagliata.
In primo luogo le rispettive diversità dei fratelli che, malgrado la condivisione biologica, si presentano come soggetti assolutamente
autonomi, e per questo, differenti l'uno dall'altro.
La potenzialità trasformativa insita nel nucleo familiare, i diversi stadi della vita genitoriale nei quali le rispettive nascite si
verificano, il differente ordine di genitura, possono inoltre esporre i fratelli a esperienze socio-affettive dissimili, anche e soprattutto
all'interno della famiglia.
È inoltre plausibile che la diversa personalità dei fratelli possa costituire un fattore differenziante nella costruzione del
rapporto con i vari membri della famiglia. Primi tra tutti i genitori: madre e padre - più o meno nello stesso modo - strutturano con
il figlio uno spazio psichico specifico e irripetibile. Da qui la nascita di una serie di microambienti familiari, sottodimensioni
in grado di evidenziare quanto le connotazioni personologiche del singolo siano in grado di direzionare il rapporto con l'altro, creando
diversità reciproche e reciprocanti pur in presenza di un legame fraterno "unitario" (Scabini e Cigoli, 1992).
Ma è proprio questo potenziale differenziante (Scabini, Cigoli, 1992) a garantire la presenza di un rapporto in cui le
reciproche diversità non vengono né esasperate - ciò esiterebbe in vissuti di invidia e rivalità reciproca -
né ignorate, perché il vissuto relazionale risulterebbe depauperato del proprio valore affettivo, ma semplicemente vissute, e
poste come base di una dinamica affettiva che si forma e si trasforma, nel tempo, senza mai distruggersi.
Il legame fraterno e l'ambivalenza inevitabile

"Considero come prima ipotesi che mio fratello, colui che mi è vicino biologicamente, con il quale condivido un retaggio
familiare, culturale, storico, è anche quello che mi ricorda in modo più realistico che non so nulla dell'origine dell'umanità.
È colui che mi fa sentire ogni giorno che la questione identitaria struttura con violenza la questione dell'angoscia legata alla
castrazione... è colui che suscita in me il desiderio più grande di distruzione, che mi consentirebbe la forclusione, la
rimozione, la denegazione di queste angosce... e la convinzione che io possa tramutare tale desiderio di distruzione in un legame, amore
fraterno, finanche in un amore passionale..." (Navelet, 2008, p. 235).
La Psicodinamica evidenzia i connotati altamente conflittuali del rapporto fraterno, riscontrando, all'interno del medesimo, la compresenza
di pulsioni ambivalenti e talvolta dicotomiche (Coles, 2004; Mori, 2012; Sommantico e Tavazza, 2006; Sommantico, 2012). In particolare la
fraternità comporta l'alternarsi tra spinte amorose proiettive e tendenze pulsionali narcisistiche, nutrite nei confronti di un
soggetto percepito come alleato, importante e tuttavia concorrente: un vero e proprio rivale (Losso, 2010; Trapanese,
Sommantico, 2011).
Il rapporto fraterno si pone l'ambizioso compito di coniugare la differenziazione del Sé con la nostalgia del tutto indifferenziato.
Da una parte il fratello costituisce il riflesso del Sé e della famiglia, la velleità di mantenere un nesso col materno
simbiotico, appagando al contempo una pulsione narcisistica. Di contro egli rappresenta la costruzione del primo modello di gruppalità,
il più arcaico legame con la dimensione sociale; per certi aspetti è l'anticipatore di quella competenza relazionale
che verrà sviluppata più avanti, e consentirà un investimento socializzante da impiegare sul lungo termine (Trapanase,
Sommantico, 2011).
Il legame fraterno è dunque un elemento di mediazione tra il narcisismo rassicurante e confermante del Sé familiare e la
differenziazione esplorativa del Sé sociale, ponendosi come elemento di frattura e di unione tra i due aspetti. In questa linea di
confine il ruolo del fratello riesce a svolgere una duplice funzione: quella di differenziazione e quella di unione simbiotica, risultando
al contempo l'esito di un intento di continuità e differenziazione con il Sé familiare (Trapanese, Sommantico, 2011).
L'ambivalenza della fratria non riguarda soltanto la compresenza tra sentimenti di affetto e rivalità, ma quella ulteriore tra
investimenti affettivi e vissuti erotizzati, con sfondo inconsciamente sessuale: si tratta dei legami fraterni definiti incestuosi, posti a
compensazione di una presenza genitoriale assente o inappagante, di cui proprio il fratello viene reso la meta surrogata. Se ne origina una
sorta di condensazione psichica - a sua volta generatrice di una sovrapposizione fantasmatica - in base alla quale i ruoli del fratello e
del genitore vanno a fondere - e confondere - i rispettivi confini funzionali, dando vita a un coacervo emotivo inevitabilmente polisemico
(Trapanese, Sommantico, 2008; Racamier, 1995).
L'arrivo dello straniero: i rapporti tra fratello maggiore e minore
Il fratello non è solo l'arrivo del pari. È soprattutto l'arrivo dell'altro, dello straniero, di colui che, con la sua
presenza giunge a infrangere l'equilibrio costituito (Losso, 2010). Se da una parte introduce la parità, dall'altra il secondo figlio
è foriero di alterità, di diversità, di novità intesa come rottura dell'omeostasi emotiva dell'intero nucleo
familiare.
Il fratello maggiore avverte questa nuova dimensione in una modalità preverbale e inconscia, in quanto percepisce la presenza del
fratello "nella mente della madre" in un momento antecedente la sua nascita, e come lei prova a immaginarne l'aspetto, la natura, le
caratteristiche, rendendolo oggetto di pulsioni fantasmatiche "desideranti".
In particolare il desiderio di avere un fratello può essere dettato dalla volontà di trovare un compagno di giochi, qualcuno
con cui creare un legame affettivo al di là di quello genitoriale. Al contempo è possibile che il bambino non voglia più
essere oggetto esclusivo degli investimenti affettivi genitoriali, specie ove questi ultimi si mostrino persecutori, aggressivi, anticipanti,
ed egli se ne senta minacciato. La speranza di avere un fratello può inoltre confondersi con l'intento di sviluppare un alter ego, di
entrare in contatto con le parti più profonde di Sé, incontrando il doppio e il perturbante (Freud, 1915), ma può anche
realizzare la fantasia edipica di fare un bambino con uno dei genitori (Kaës, 2008).
Il vantaggio collegato a queste prospettive non riesce tuttavia a stemperare un'inevitabile diffidenza verso il nascituro, il cui arrivo,
nell'immaginario del maggiore, è collegato a vissuti di perdita, di minaccia, di messa in ombra (Losso, 2010).
La prospettiva di dover condividere tutto ciò di cui fino a quel momento si è goduto in via esclusiva costituisce un autentico
contraccolpo per il marcato egocentrismo infantile, soprattutto se l'oggetto materno non si mostrerà in grado di identificare il
disagio e di rielaborarlo con responsività, cercando di stemperare le inevitabili angosce di separazione e di perdita.
Melanie Klein (1923) sottolinea la difficoltà di coesistenza sperimentata durante i primi anni: gelosie nei confronti del fratello
più piccolo o più grande, desideri sadici sperimentati verso il figlio più piccolo che si sente squalificato dal
più grande o non considerato dai genitori. Ciò può tradursi nella produzione di agiti comportamentali conflittuali,
talvolta persino aggressivi, simbolo di un'ambivalenza inconscia e ingestibile: dunque un fratello più piccolo può risultare
maltrattato o oppresso da parte del maggiore, per poi essere dallo stesso difeso all'esterno del nucleo familiare; un fratello può
rivelarsi un alleato contro le proibizioni educative comuni, così come un avversario nella conquista delle attenzioni genitoriali;
con la medesima velocità il fratello è destinato a trasformarsi da compagno di giochi a nemico, da appoggio insostituibile a
ostacolo da eliminare.
La difficoltà nel rapporto può essere amplificata da una differenza di età eccessiva o ridotta, così come dalla
diversità di genere, soprattutto in quelle culture ove l'educazione femminile e quella maschile ricevono un trattamento ad esclusivo
appannaggio di quest'ultima.
La Psicologia evolutiva osserva come il fratello maggiore tenda a sperimentare, nei confronti del minore, ove un senso di gelosia, specie
se la differenza di età risulta minore di 5 anni, ove un senso di protezione, soprattutto se un dislivello cronologico considerevole
(pari o superiore almeno a 7 anni) rende il fratello maggiore una sorta di figura genitoriale sostitutiva, privata di ogni connotato
competitivo nei confronti dell'altro (Cannoni, 2002). In questo caso sono gli stessi genitori a enfatizzare i comportamenti di
responsabilità da parte del primogenito, che viene letteralmente parentificato e investito del ruolo di "guardiano" del fratello,
soprattutto in situazioni che richiedono una maggior necessità di controllo, autoregolazione e disciplina.
Al contrario, nel caso in cui la differenza di età si mostri irrisoria, i fratelli vengono generalmente sottoposti a un modello
educativo simmetrico, in cui il livello di responsabilità risulta equamente distribuito. È questo lo scenario in cui i
componenti della fratria possono godere a pieno della reciproca presenza, percependola come strumento attivatore di funzioni stimolanti,
contenitive e di appoggio, finalizzate a una crescita co-costruita del Sé, in grado di evitare un'intensificazione distruttiva dei
conflitti (Klein, 1923).
Da questo punto di vista la Psicologia evolutiva sottolinea l'importanza del ruolo genitoriale come mediatore adattivo della
conflittualità fraterna: le relazioni tra fratelli presentano un minor grado di contrasto se i genitori sono in grado di mantenere
condotte di trattamento egualitarie e non parzialmente a favore dell'uno o dell'altro. Allo stesso modo, famiglie in cui il conflitto
genitoriale mostra livelli meno esacerbati sono in grado di generare legami fraterni più duraturi (Cummings et al. 2006). Non si tratta
dunque soltanto di una dimensionalità intrapsichica: è necessario riconoscere al legame fraterno una natura interpsichica in
cui la condotta affettiva genitoriale svolge un ruolo di indubbio valore adattivo-protettivo, anche sul lungo termine.
E il secondogenito?
Se agli occhi del fratello maggiore il secondogenito rappresenta il rivale, l'intruso, "l'altro", di rimando il minore percepisce
nel primogenito un connotato di superiorità - supposta o oggettiva - che lo rende imperfetto, incompleto. L'eterno secondo.
Il vissuto del suo Sé viene a connotarsi di un'inconscia frustrazione che lo spinge a un'imitazione del fratello, compensativa e
tuttavia non pienamente gratificante, perché in opposizione al desiderio di un nucleo identitario che ambisce a emergere in autonomia.
Da qui il continuo alternarsi di condotte identificative e contro identificative, poste in essere al fine di creare la giusta distanza tra
il Sé individuale e quello del maggiore, attingendo dallo stesso pur eludendone la minaccia pervasiva.
Per quanto avvantaggiati dal fatto di non dover sperimentare la nascita di un nuovo arrivato e dall'essere destinatari di una certa indulgenza
educativa si aggiunga che, anche agli occhi dei genitori gli ultimogeniti rivestono un ruolo di minor responsabilità; e se questo
significa una minore attribuzione di colpa e di stigma nei vari modelli educativi, si tramuta al contempo in un ruolo di più limitata
autorità e meno marcata posizione all'interno della gerarchia familiare.
Allo stesso tempo, sembra che il minor coinvolgimento del secondogenito all'interno dei legami familiari gli consenta una separazione meno
sofferta, e con essa la maturazione di un senso di indipendenza e autonomia che spesso lo conduce in direzioni notevolmente lontane da quelle
nucleari, per sperimentare le proprie abilità sociali e affermarsi come individuo (Cannoni, 2002).
L'impulso di differenziazione e distacco ritornerà come un filo conduttore nella vita del fratello minore, soprattutto
dell'ultimogenito, che vedrà nello svincolo familiare uno strumento di affermazione e costruzione del Sé (Oliviero Ferraris,
1973).
Studi specifici hanno riscontrato come sia il fratello minore a manifestare una più spiccata propensione relazionale, e come sia sempre
l'ultimogenito a mostrare minori problemi di inserimento nel contesto scolastico e un meno disagevole confronto con i pari. In particolare
si è notata la minore vulnerabilità del secondogenito allo sviluppo della fobia scolastica, la cui matrice eziopatologica viene
identificata in un'angoscia di separazione dall'oggetto materno (Racamier, 1995; Coolidge, 1979).
Sembra inoltre che la fantasia fusionale con la madre avvertita - più marcatamente dal fratello maggiore - venga amplificata dallo
stesso vissuto materno, che nel rapporto con il primogenito si presenta sottoforma di un narcisismo onnipotente-simbiotico. La madre stessa,
in definitiva, tenderebbe a sfavorire lo svincolo del maggiore dal contesto diadico, la cui esistenza viene perpetrata nello spazio psichico
di entrambi come un elemento confermante (Racamier, 1995).
La rivalità fraterna: aspetti psicodinamici
La rivalità fraterna affonda le radici in uno stadio esistenziale arcaico in cui i fratelli si trovano a occupare un ruolo
essenzialmente competitivo: le pulsioni di entrambi ambiscono a raggiungere una meta analoga, identificabile nell'oggetto materno, e
in questa lotta ognuno cerca di sopraffare l'altro. Non è ammessa la condivisione delle risorse, né della meta pulsionale:
l'esclusione reciproca è necessaria a garantire il possesso esclusivo della madre e dei beni di cui la stessa si fa portatrice (Coles,
2004). Si fa riferimento al conflitto di Caino proprio per indicare il vissuto di rivalità che porta i fratelli a combattersi
e a squalificarsi l'un l'altro, più o meno larvatamente, al fine di perseguire una condizione di privilegio nel godimento delle risorse
genitoriali o più generalmente familiari.
Lo scenario di rivalità percepito dal maggiore si amplifica nel caso in cui la nascita del secondogenito si verifichi durante la fase
edipica, di per sé connotata da vissuti di intensa gelosia competitiva nei riguardi del genitore di sesso opposto.
Ma il problema comportato dalla nascita del fratello coinvolge anche la stessa dimensione autopercettiva, imponendo l'accettazione di una
realtà differenziante, in cui l'estraneo si introduce non soltanto all'interno del contesto diadico, ma nei confini dello stesso
Sé, limitandoli ineluttabilmente (Laplanche, 1930).
"Il complesso fraterno ha specificamente il problema di risolvere il ruolo dell'alterità. Non quella dell'alter ego, dove
l'identico conosce, assorbe o ingloba l'altro, ma l'alterità insormontabile, l'esistenza che non si condivide. Il legame con questo
altro oggetto esterno si inscrive nella realtà: costringe ad uscire da sé e si pone come esperienza che dona libertà"
(Bourguignon, 1999, p. 88).
E ancora: "il legame fraterno è quella relazione psichica tra due o più soggetti che si prendono l'un l'altro per una
proiezione scissa di se stessi (io sono/non sono come lui), dando vita ad una relazione strutturante che, favorendo la differenziazione e
l'entrata dell'altro nella simbiosi diadica, attiva tutti i processi pulsionali e i meccanismi di difesa che solitamente sono coinvolti nella
costituzione soggettiva intesa come nascita del Sé individuale" (Navelet, 2008, p. 237).
La comparsa del fratello mette alla prova la capacità adattiva egoica, perché disegna un confine indelebile nel Sé
megalomanico infantile, disilludendo un'illusione di onnipotenza che nutre e conferma. È il primo contatto con il principio di
realtà, la cocente limitazione degli impulsi improcrastinabili dell'Es.
Da qui la percezione della presenza fraterna come una sconfitta individuale, spesso gestita con meccanismi difensivi arcaici - regressione,
negazione e proiezione - o più maturi - formazione reattiva, rimozione, spostamento - che si consolidano divenendo parti integranti
della dimensione caratteriale.
Il legame fraterno, oltre ad essere vissuto, viene infatti interiorizzato: esso diventa un frammento inconscio, arcaico, incistandosi nel
Sé come un oggetto talvolta supportivo, talvolta traumatico, invasivo, persecutorio.
Il gruppo di fratelli e sorelle, dal punto di vista psicoanalitico, costituisce un insieme di oggetti parziali che vengono riproposti come
modello di investimento nelle varie esperienze di coppia, nei legami sociali, nel setting terapeutico (Kaës, 2008).
... Il fantasma del fratello fa sovente la propria comparsa all'interno del setting terapeutico, contaminando vissuti di transfert
e controtransfert operanti nella cura: fratelli e sorelle perduti, frustranti, danneggiati, incestuosi, mediatori, che sono tutti allo stesso
tempo compagni di sviluppo nella realtà e modellatori transferali (Graham, 1988, p. 87).
È spesso più difficile separarsi dall'immagine interiorizzata di un fratello che dal fratello stesso, soprattutto nel caso
in cui la presenza di questa immagine mostri una carica pulsionale persecutoria, ostacolante la formazione di un Sé consapevole e
assertivo.
Non solo nemici...
Gli aspetti di minaccia, negatività e competizione appena esposti non sono sufficienti a privare il legame fraterno di risvolti
marcati di unione, in grado di tradursi in vissuti affettivi reciprocanti che si preannunciano duraturi e stabili. E così accade che
la rivalità si lasci spesso scalzare, o quanto meno stemperare, dall'innata pulsione di condivisione che lega i fratelli, e dal
desiderio, nutrito da entrambi, di poter contare l'uno sulla presenza dell'altro.
In verità i fratelli vengono in soccorso reciproco, nei momenti di necessità che possono verificarsi durante tutto il corso
della vita.
I benefici apportati dalla presenza fraterna assumono connotazioni diverse nelle varie fasi evolutive:
- in età infantile i contrasti fraterni contribuiscono alla formazione della teoria della mente, facilitando la comprensione di false credenze e l'acquisizione di una capacità di negoziazione e gestione del conflitto;
- durante l'adolescenza la presenza del fratello può svolgere un ruolo supportivo nella gestione del contrasto col genitore, rendendo più agevole la de identificazione e lo svincolo identitario dallo stesso;
- in una fase più avanzata della vita il legame fraterno può rivestire un punto di riferimento a cui aggrapparsi nel caso di difficoltà, solitudine o malattia, specie nei casi di vedovanza. In particolare si è visto come le sorelle siano in grado di prendersi cura dei fratelli, e come di rimando siano questi ultimi, anche in età senile, a poter contare maggiormente sul sostegno sororale, laddove le sorelle appaiono disposte ad accettare con più facilità anche il supporto sociale esogamici, e dunque esterni alla famiglia (Scabini e Cigoli, 2000).
La Psicologia evolutiva testimonia come non siano rari i casi in cui la presenza fraterna si mostri un valido surrogato della presenza
genitoriale, talvolta sostituendola in toto.
In molti casi si parla di famiglia di fratelli, dato come il potenziale di difesa e di sostegno reciproco che questo legame è
in grado di apportare in situazioni deprivanti dal punto di vista affettivo, o di autentico lutto - ad esempio la morte di un genitore -
consenta di affrontare con resilienza esperienze traumatiche che rischierebbero di disintegrare i legami e le identificazioni (Scabini e
Cigoli, 2000).
In conclusione, è indubbio che il fratello rappresenti la prima relazione sociale instaurata dal bambino, o almeno la prima
instaurata con un pari, e questo senso di investimento sociale serve anche a rafforzare l'identità del Sé, che nell'altro si
riconosce e si potenzia (Freud, 1921).
I fratelli rappresentano pertanto i creatori del "gruppo dentro la famiglia" (Brunori, 1997), una sottocategoria alternativa e tuttavia
complementare a quella genitoriale.
Il richiamo dell'omogeneità biologica è forte, e la convivenza contestuale fa il resto. Essi si trovano a vivere le medesime
vicissitudini familiari, a condividere gli stessi ricordi e le medesime relazioni oggettuali, sebbene sviluppate in modalità e tempi
diversi, e questo li porta a nutrire un'inconscia conoscenza reciproca cosciente, che sarà in grado di unirli per sempre, malgrado
la diversità delle rispettive direzioni evolutive, in una sorta di struttura parentale con la quale garantire la continuità
dell'identità familiare e personale (Losso, 2010).
Al di là di ogni possibile interpretazione psicologica, sembra che la presenza di un fratello all'interno del nucleo familiare sia
funzionale allo sviluppo di una maggiore capacità relazionale, di senso empatico, di altruismo e di condivisione, e questo sin dalle
prime fasi della vita, dato come i bambini, stante la pluralità filiale in famiglia, vengano precocemente a contatto con una dimensione
esistenziale in cui i valori, i beni e le risorse necessitano di condivisione, e il senso esistenziale dell'uno deve essere costruito in una
dinamica reciproca e interagente.
In presenza di un contesto affettivo stabile e sicuro la presenza del fratello potrà inoltre mostrarsi funzionale allo sviluppo di
vissuti prosociali, alla capacità di sviluppare aspetti relazionali tesi a prendersi cura dell'altro, a potenziare competenze di
regolazione emotiva, di differimento della gratificazione pulsionale, di differenziazione del Sè da quello della madre: il tutto in
una dimensione socialmente orientata.
"È importante considerare il destino del legame fraterno nel tempo. Di tutte le relazioni familiari essa è quella
destinata ad avere una maggior durata. Essa accompagna le persone anche venti o trent'anni oltre quella coi genitori" (Scabini e
Cigoli, 2000, p. 32). I fratelli sono i destinatari di un mandato familiare che dura nel tempo e si rinnova.
L'unione fraterna resta tra le più intense e durature. Tra le più generative e poietiche, per questo in grado di attraversare
una memoria storico-affettiva che si reitera al di là del tempo, malgrado le difficoltà e i cambiamenti imposti dalla vita
(Cigoli, 1992), riconoscendo in se stessa il senso di una radice affettiva, più ancora che biologica, in grado di unire
indissolubilmente coloro che ne fanno parte.
Bibliografia
- Bourguignon O. et al. (1999), Le fraternel, Dunod, Parigi
- Brunori L. (1997), Gruppo di fratelli. Fratelli di gruppo, Borla, Roma
- Cannoni E. (2002), Amici e fratelli. Effetti dell'esperienza fraterna sulla rappresentazione di relazioni interpersonali infantili, in Età evolutiva, 73, pp. 40-47
- Coles P. (2004), Le relazioni fraterne nella psicoanalisi, Astrolabio, Roma
- Cigoli V. (1992), Il corpo familiare, FrancoAngeli, Milano
- Coolidge J.C. (1979), School phobia, in Noshpitz J.D., Basic Handbook of Child Psychiatry (a cura di) Basic Books, New York, vol. II, pp. 453-463
- Cummings E.M. et al. (2006), Interparental discord and child adjustment: prospective investigations of emotional security as an explanatory mechanism, in Child Development, 77, pp. 132-152
- Freud S. (1905), Tre saggi sulla teoria sessuale, Bollati Boringhieri, Torino, 2012
- Freud S. (1919), Il perturbante, Bollati Boringhieri, Torino, 1991
- Freud S. (1921), Psicologia delle masse e analisi dell'Io, Freud, Opere, Vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino
- Freud S. (1914), Introduzione al narcisismo, Freud, Opere, Vol. 7, Bollati Boringhieri, Torino
- Laplanche J. (1970), Vita e morte in psicoanalisi, Laterza, Bari, 1972
- Losso R. (2010), Psicoanalisi della famiglia. Percorsi teorico-clinici, FrancoAngeli, Milano
- Kaës R. (2008), Il complesso fraterno, Borla, Roma, 2009
- Kerr M.E. (1991), Family system: theory and therapy, in Gurman A.S., Kniskern D.P., (a cura di), Handbook of family therapy, New York, Bruner/Mazel
- Kim J. (2006), Longitudinal course and family correlates of sibling relationships from childhood through adolescence, in Child Development, 77, pp. 1746-1761
- Klein M. (1921-1923), Lo sviluppo libidico del bambino, Bollati Boringhieri, Torino, 2013
- Klein M. (1923), La psicoanalisi dei bambini, G. Martinelli, Firenze, 1969
- Mori L. (2012), Scenari dei legami fraterni, Le Lettere, Firenze
- Navelet C. (2008), Fratello, fratria e legami fraterni: dalle parole al concetto, in La dimensione fraterna in psicoanalisi, a cura di Trapanese e Sommantico, Borla, Roma
- Oliverio Ferraris A. (1973), Il significato del disegno infantile, Bollati Boringhieri, Torino
- Racamier P.C. (1995), Incesto e incestuale, FrancoAngeli, Milano, 2003
- Scabini E., Cigoli V. (2000), Il famigliare. Legami, simboli e transizioni, Raffello Cortina, Milano
- Sommantico M., Tavazza G. (2006), Fratelli: vincolo e risorsa, FrancoAngeli
https://www.torrossa.com/it/resources/an/4133569
Altre letture su HT
- Giulia Regoli, "L'ombra della famiglia. Recensione Film: The Fighter", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 62, 2011
- Valentina Zappa, "Recensione Test: Il Disegno della Famiglia", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 112, 2014
Cosa ne pensi? Lascia un commento
| Condividi! | |
 P.IVA 03661210405 © 2001-2025
P.IVA 03661210405 © 2001-2025HT Psicologia - Il rapporto fraterno: tra legame e conflitto




