
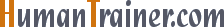
HT: La Psicologia per Professionisti
Disturbi alimentari e sessualità: una visione lacaniana
 Istituto di Fototerapia Psicocorporea - Formazione & Corsi
Istituto di Fototerapia Psicocorporea - Formazione & CorsiCorso intensivo di Fototerapia Psicocorporea - Bologna
 IRIS - Insegnamento e Ricerca Individuo e Sistemi
IRIS - Insegnamento e Ricerca Individuo e SistemiScuola di specializzazione in Psicoterapia - Milano

Disturbi alimentari e sessualità: una visione lacaniana
I Disturbi Alimentari nel mondo dell'agio contemporaneo
- Incontro con la sessualità, femminile e maschile
- Anoressia, tossicomania e conversione corporea
- Legame con il padre e trasformazioni della pubertà
Articolo: 'Disturbi alimentari e sessualità: una visione lacaniana
I Disturbi Alimentari nel mondo dell'agio contemporaneo'
- INDICE: Disturbi alimentari e sessualità: una visione lacaniana
- Premessa
- L'adolescenza come incontro con la differenza sessuale
- Come è possibile, per una ragazza, diventare donna?
- L'amore padre-figlia
- Note
- Altre letture su HT
Premessa
Ero un giovanissimo studente fuori sede alle prese con l'ambientamento in un contesto nuovo, in una città a me sconosciuta e con un
metodo di studio diverso da quello del gruppo-classe che si preparava per le verifiche con i docenti. Da poco mi ero trasferito a Padova, dove
frequentavo il primo anno di Università, in una delle più antiche Università europee.
Tornando a Como, come al solito, per il weekend, venni a sapere che una ragazza del mio gruppo di amici dei tempi del Liceo soffriva di una forma
severa di anoressia.
Lorena era una bella ragazza, di qualche anno più giovane di me: alta, dotata di un'intelligenza sensibile, di una consueta
allegria, con degli splendidi occhi azzurri, forse leggermente sovrappeso. Mi dissero che non mangiava quasi più nulla, che si nutriva
soltanto di pochissima frutta e verdura, di una mela al giorno.
Nella scuola superiore a cui era iscritta, continuava a conseguire ottimi risultati e votazioni, pur manifestando dei momenti di apparente
assenza, in cui la vedevano assorta a contemplare il vuoto, con uno sguardo vagamente perplesso.
Non lo sapevo ancora da neofita allievo della Facoltà di Psicologia, privo di qualunque pratica clinica e sopratutto dell'esperienza analitica soggettiva, eppure sempre avviene così: l'interesse per una problematica psicopatologica trae origine da un incontro strettamente personale oppure familiare, da un interrogativo inerente il campo dell'amicizia o quello dell'amore.
Ci si interroga sull'isteria quando si ha una madre che lascia sempre insoddisfatto il proprio desiderio, oppure si incontra una ragazza
la cui difesa da qualsivoglia soddisfacimento sessuale lascia sorpresi.
Si avverte con inquietudine e angoscia l'esigenza di saperne di più sulle psicosi quando si scopre qualche tratto di follia in noi
stessi, oppure quando si conosce qualcuno il cui delirio si manifesta nel modo più eclatante ed improvviso, lasciando i conoscenti
stupiti a domandarsi cosa possa essere accaduto.

Nel caso suddetto, la trasformazione radicale del corpo di Lorena ebbe un certo effetto sul sottoscritto. Agli occhi di chi l'aveva
conosciuta precedentemente, non passava inosservata: le sparirono tutte le forme femminili e le apparvero delle profonde occhiaie sul viso;
le sue amicizie si ridussero all'osso tanto da evitare risolutamente ogni frequentazione del nostro gruppo e, più in generale, delle
aggregazioni di teenager, preferendo smettere di coltivare legami.
Questo fu il primo momento in cui mi cominciai a domandare, esterrefatto, cosa potesse spingere una diciassettenne a stravolgere in modo tanto
drammatico la propria esistenza con questo dimagrimento forsennato.
Non vi è, in effetti, problematica più diffusa nelle adolescenti dei Disturbi del Comportamento Alimentare. Basta svolgere un progetto di consulenza rivolto agli insegnanti, oppure gestire uno sportello di ascolto in una qualsiasi delle plurime scuole superiori con un'elevata presenza di ragazze fra gli iscritti, oppure venire chiamati a collaborare con una società sportiva femminile, per accorgersene ampiamente.
Una società che conferisce sempre più rilevanza a determinati modelli e canoni estetici, il culto dell'immagine del corpo magro, i modelli di bellezza attuali - che rappresentano le donne in forma androgina - sono soltanto alcuni fra i molteplici fattori che hanno determinato, ormai da alcuni decenni a questa parte, una diffusione epidemica dei disturbi dell'alimentazione fra le teenager dei paesi occidentali.
La contestualizzazione socio-economica di queste condotte e di queste pratiche risulta fondamentale in quanto esse non avvenivano in epoche storiche precedenti, se non in famiglie nobili e nelle corti dei regni. Nota è l'ottocentesca figura della Imperatrice d'Austria Sissi, cui sono stati dedicati romanzi storici e un cartone animato, oltre a una serie di film, la quale avrebbe sofferto da giovane di un'importante anoressia con pasti frugali e sporadici in una logica di ribellione che l'avrebbe caratterizzata.
La restrizione dell'alimentazione non sarebbe potuta avvenire fra la gente comune, impegnata com'era nella lotta per la sopravvivenza, dinanzi
agli stenti e alle ristrettezze alimentari che caratterizzavano la gran parte della gente.
Tuttora vi sono ampie fette della popolazione mondiale in condizioni di drammatica indigenza, le quali non potrebbero mai inscenare una
provocazione inerente la riduzione del nutrimento, non avendo la sicurezza di poterne avere a disposizione l'indomani.
Vi sono, poi, altri motivi inerenti tematiche relative alla sessualità e alla separazione dell'alveo familiare che
sarebbe ingenuo tralasciare.
Il primo tipo di lettura è fondamentalmente di tipo sociologico-pedagogico, il secondo squisitamente psicoanalitico.
Sicuramente possiamo considerare i Disturbi dell'Alimentazione come la forma più comune di dipendenza al femminile.
Mentre gli adolescenti maschi sono solitamente volti a sperimentare l'ebbrezza indotta da vari tipi di bevande alcoliche e di stupefacenti,
per la priorità che conferiscono al godimento prodotto dagli oggetti inebrianti, le ragazze tendono a far ruotare la loro economia
libidica intorno all'immagine corporea e al cibo come oggetto pulsionale.
Tale dipendenza risulta facilmente accostabile a quella tossicomanica quando prende la piega delle abbuffate bulimiche, dell'alimentazione incontrollata nel Binge Eating Disorder e del riempimento smodato delle grandi obesità; meno chiara è, all'apparenza, la dipendenza dal cibo sul lato - per certi versi più drammatico e urgente - dell'anoressia restrittiva.
L'adolescenza come incontro con la differenza sessuale
Vi è un'evidenza clinica imprescindibile e impossibile da tralasciare, già più volte citata:
i nuovi sintomi si presentano molto più spesso nell'adolescenza che in altri periodi della vita, soprattutto più spesso che
nell'infanzia.
Per Sigmund Freud, nella pubertà, «La pulsione sessuale si pone al servizio della funzione procreativa; diventa per
così dire altruistica»1, per cui la sessualità piegata alla genitorialità, alla paternità
fa coincidere maschile e femminile nel desiderio di procreare.
L'innamoramento, così appassionante nei teenager, decantato ad esempio dai libri di Federico Moccia da cui sono stati tratti diversi cult movie per adolescenti, costituisce sempre un incontro mancato perché, ad esempio, vi è sempre uno scarto fra il godimento maschile e il soddisfacimento femminile. I lucchetti dell'amore, incardinati sul Ponte Mario a Roma - e che hanno trovato in altre città europee degli epigoni - costituiscono un emblema di rendere il legame eterno, inscalfibile.
Nella sessualità ci si accorge però del godimento femminile come non tutto fallico.
Il godimento maschile è fallico, localizzato sull'organo sessuale.
Il godimento femminile risulta invece meno localizzato, maggiormente diffuso nel corpo, più vicino all'illimitato della follia.
Questa differenza crea spesso ansia nell'incontro con la sessualità.
Il ragazzo dovrebbe accettare la propria mancanza e il fatto di trovare non La donna ma una donna come causa del proprio desiderio;
la ragazza di essere l'oggetto causa di desiderio, di essere il fallo e non tanto di avere il fallo.
L'adolescente si pone la questione della sua esistenza nel campo dell'Altro.
Per l'adolescente c'è il presentarsi ricorrente - come detto - dell'interrogativo:
"Chi sono io?". Questo punto di domanda si declina in forme diverse nelle varie strutture cliniche; nell'Isteria prevale il lato sessuale
della questione e tale interrogativo sull'identità sessuale si presenta come: "Sono uomo o sono donna?"; mentre, nella Nevrosi
ossessiva, risulta più tormentosa la preoccupazione circa il nostro destino mortale e la domanda giunge dunque come: "Sono vivo o sono
morto?".
Sono domande fondamentali quanto alla sessualità, quanto alla morte sulle quali non vi è una risposta assoluta nel campo
dell'Altro, nel campo del linguaggio.
Non sapremo mai con certezza assoluta cos'è la morte, cosa vi è o non vi è dopo la morte, se esiste o no un mondo
ultraterreno e ultrasensibile, quanto rimarrà misterioso il campo della sessualità e, in particolar modo, della sessualità
e del godimento femminile in assenza di sue manifestazioni così chiare e incontrovertibili come quelle dell'erezione e dell'eiaculazione
maschile.
Perciò le risposte monosintomatiche: "Sono anoressica", "Sono tossicodipendente" non affrontano tali questioni basilari
e divengono un modo per evitarle.
Funzionano come insegne sociali che procrastinano tali interrogativi, garantendo comunque l'assunzione di un'identità che evita
l'incontro sempre sofferto con la sessualità.
Queste insegne offrono anche un'identità di genere: l'anoressia risulta quasi esclusivamente femminile e punta a fornire un'identità femminile senza passare per la sessualità. La tossicomania è tipicamente maschile e si caratterizza per un modo di godimento che - come diceva Jacques Lacan nella sua ultima affermazione circa le droghe - permette di rompere il matrimonio con il fallo e il godimento fallico, offrendo l'opportunità di un godimento assoluto, smarcato dalla sessualità e, proprio per questo, pericolosamente mortifero.
La mia tesi fondamentale è che vi sia una articolazione complessa fra la sessualità e il disturbo alimentare. In alcune ragazze, quando vi è la fase restrittiva rispetto all'alimentazione si instaura anche una parallela chiusura sul piano degli incontri sessuali. Dunque vi è una prevalenza dell'Ideale paterno, dell'Ideale del corpo magro, di un Ideale di purezza e castità sulla pulsione: avviene così un trionfo sulla pulsione che Melanie Klein definirebbe probabilmente di stampo maniacale.
Questi casi sopra descritti sono contraddistinti da un mantenimento del legame padre-figlia. Quando la padronanza ideale sulla pulsione crolla, ad esempio dopo una delusione subita da parte del padre amato ed amante, subentra una certa esperienza depressiva e vi è un viraggio verso le abbuffate bulimiche, seguite o meno da condotte di smaltimento delle calorie introdotte nel corpo, fra le quali il vomito è soltanto una delle molteplici opzioni.
In questi frangenti emerge anche una posizione più libertina nella sessualità, concretizzata da una sorta di bulimia
sessuale con numerose esperienze erotiche, con svariati ed effimeri incontri intimi.
Vi sono, però, anche diverse ragazze che funzionano in una logica inversa per cui la frequenza dei contatti sessuali è
inversamente proporzionale alle abbuffate bulimiche.
In questi casi, quando vi è un'apertura verso la sessualità, riscontriamo una riduzione dei momenti di assunzione incontrollata
degli alimenti; nelle fasi di prevalenza del disturbo bulimico, abbiamo invece un rarefarsi degli incontri sessuali.
In queste situazioni cliniche, più rare nella mia esperienza, abbiamo dunque una logica di sostituzione: il godimento dell'abbuffata rimpiazza quello sessuale e, quando la dialettica del desiderio torna in primo piano, il soddisfacimento inerente al cibo tende a sgonfiarsi e stemperarsi.
Ad esempio, Tatiana, una giovane poco più che adolescente, dopo molti mesi di trattamento, forzandosi a fatica a lasciar cadere le inibizioni che la attanagliavano, fece accenno alla sua convinzione intimamente radicata in base alla quale il suo Binge Eating Disorder fosse correlato a una questione di tipo sessuale. Ci vollero alcune altre sedute perché arrivasse a vergognarsene un po' di meno tanto da poter enunciare cosa intendeva: si era accorta di come le abbuffate sostituissero un altro tipo di godimento, autoerotico, assurto a baluardo che la riparava dagli agìti sessuali.
Nella masturbazione, svolta nella casa dove abitava con i genitori e le sorelle, quando loro erano assenti, si crogiolava nella fantasia di degradarsi, avendo contatti intimi con molteplici uomini, sconosciuti. L'immaginario erotico di Tatiana era, dunque, popolato da desideri sessuali analoghi a un'abbuffata di uomini e di sesso, da "mangiatrice di uomini".
Il suo sintomo clinico, il Binge Eating Disorder, costituiva una sorta di sostituzione dunque di queste fantasie: nelle fasi di astinenza sessuale, infatti, ella ripiegava sul godimento di ingoiare tutta una serie di alimenti, anzitutto dolciastri, mentre rimuoveva tali desideri erotici dalla sua intimità.
Come è possibile, per una ragazza, diventare donna?
"Cosa vuole una donna? Cos'è una donna?".
Ecco uno dei due fondamentali interrogativi che, insieme alla questione su cosa sia essere padre, si poneva Freud.
L'inventore della Psicoanalisi si è sempre interrogato su questa tematica rispondendo attraverso tre figure di donna, tutte posizionate
in riferimento a quel fondamentale operatore logico che è il fallo, elemento cardine della differenza sessuale.
La vergine che rifiuta il fallo, la fanciulla dall'identificazione virile affetta dal complesso di mascolinità e la
madre che accetta di ricevere il fallo sotto forma di bambino da un uomo sostituto del padre costituiscono i tre emblemi della
femminilità freudiana.
E Freud sembra prediligere la via materna come forma di risoluzione della problematica assunzione della posizione femminile nella bambina.
Si nota, in genere, come sia meno comune la domanda "Cos'è essere un uomo?" proprio in quanto tale quesito ha già una
risposta sul piano dell'avere fallico.
Non esistendo un elemento che definisca in toto una donna, su questo lato della soggettività rimane un'aura di mistero, di enigma.
La questione inerente alla femminilità si riapre nell'opera di Jacques Lacan, il quale pure si considerava il più rigoroso lettore di Freud, a partire dalla non coincidenza della posizione madre con la posizione donna. Si tratta di un rapporto fondamentale poiché la Psicoanalisi nacque proprio dal dare la parola al soggetto isterico e, soprattutto, alle pazienti isteriche da parte di Breuer e Freud.
L'importanza del metodo analitico della talking cure riposava sulla specifica congiuntura culturale della società vittoriana
che rimuoveva il discorso relativo alla sessualità.
Si trattava, allora, di parlare della sessualità solo a tempo debito, nel luogo opportuno in una logica sociale che scandiva un sistema
di posizioni, un gioco di ruoli volto a ritagliare una zona di silenzio, uno spazio interdetto circa l'intimità erotica.
In questa zona, solo attraverso il sintomo di conversione corporea il soggetto poteva prendere la parola.
Tra madre e donna c'è una differenza. Se la teoria di Freud e quella di Lacan per molti anni ponevano l'accento sull'avere e non avere
il fallo, il Lacan degli anni Settanta accentua la distinzione fra il godimento fallico e un'altra soddisfazione.
Si tratta di una forma di soddisfacimento, non precluso all'uomo ma precluso dal simbolico, che va al di là del fallo quale significante
essenziale nell'inconscio.
Il godimento femminile non è limitato a quello fallico ma va oltre.
Non è appropriato descrivere, invece, un desiderio femminile in quanto vi è una sola libido, maschile e fallica. Questo è
il motivo per cui il desiderio, imperniato su di un fantasma inconscio fondamentale, si pone più dal lato maschile mentre la posizione
femminile ha un rapporto più intimo con l'amore.
L'amore padre-figlia
Non sempre il padre risulta inesistente per la figlia, non sempre diventa irrilevante, persino nell'epoca del declino dei papà, che
sono oggi storicamente in difficoltà nello svolgimento del loro compito genitoriale. Vi sono anzi molti legami solidissimi fra padre e
figlia, incorruttibili con il trascorrere del tempo, resistenti al passare degli anni.
L'affetto intenso provato dal papà nei confronti della bambina, che costituisce per lui motivo di grande gioia, può restare
immutato anche alle soglie della pubertà.
La bimba può diventare per il papà una sorta di nuova partner, ad esempio nel caso della separazione dalla moglie nonché madre della figlia, instillando in lei l'idea di rimanere unica, eccezionale per lui in un afflato che prosegue invariato. Certi contatti corporei, alcune tenerezze, determinate coccole fra il papà e la figlia, in particolar modo quando si tratta di una figlia unica, costituiscono un emblema dell'intimità coinvolgente e struggente che la ragazza stenterà a rintracciare nei coetanei. Questo renderà problematica la sostituzione del papà con un fidanzato oppure, ancora più, con un marito.
La questione del legame padre-figlia si situa a livello della trasmissione generazionale diversa rispetto a quanto avviene fra il papà e il bambino. Il figlio maschio dovrebbe ricevere in eredità dal padre qualcosa sul piano dell'avere: ad esempio, avere le sue passioni, proseguire nel suo lavoro, ereditare la sua casa, assumere il suo desiderio, acquisire certe sue convinzioni, posizionarsi in un'identità virile.
Per dirlo in breve, con una parola che riassume tutti questi concetti, si tratta di trasmettere al figlio l'esercizio del fallo.
Questo passaggio di competenze sarà ovviamente sempre incompleto e lascerà spazio a invenzioni creative del figlio nello sviluppo
della sua originale soggettività ma orienterà, tuttavia, buona parte della sua esistenza maschile.
La posizione femminile implica il già citato campo del godimento femminile, non tutto fallico, non tutto centrato sull'organo e più diffuso nel corpo ma, fondamentalmente, a livello simbolico non tutto basato sull'avere.
Cosa dovrà trasmettere il papà alla figlia femmina?
Passioni, lavoro, casa, interessi rimangono sicuramente delle eredità importanti, ma situano sul lato dell'avere il fallo, mentre una
posizione femminile non-tutta fallica implica il lato dell'essere.
Una figlia dovrà allora trarre dal papà oltre che dalla madre dei tratti di sensibilità, di dolcezza, di tenerezza che
la renderanno una donna che è sensibile, dolce, tenera.
In un'atmosfera di frequente seduzione reciproca, il papà si troverà a dover dare dell'amore. Molte figlie, dunque, porteranno
sempre con loro la traccia mnestica dell'essere amata dal padre.
Nei disturbi alimentari, soprattutto in quelli sul lato anoressico, vi può essere il far sparire le forme femminili del corpo per
protrarre il legame con il papà, nella logica del rinviare l'adolescenza.
Il momento della pubertà diventa in questi casi traumatico in quanto dovrebbe portarla a investire l'originario amore nei confronti
del padre verso un coetaneo.
Le trasformazioni del proprio corpo, che cambia assumendo fattezze da donna, vengono spesso vissute con inquietudine e possono determinare un movimento regressivo con un ritorno verso l'infanzia volto a far perdurare l'amore padre-figlia, un amore privo di approcci sessuali.
Note
- Luchetti A. (a cura di), Sigmund Freud (1905), "Tre saggi sulla teoria sessuale", BUR, Biblioteca Universale Rizzoli - Classici del pensiero, 2010
Altre letture su HT
- Piergallini A., " Fame di niente", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika nr. 60, 2011
Cosa ne pensi? Lascia un commento
| Condividi! | |
 P.IVA 03661210405 © 2001-2025
P.IVA 03661210405 © 2001-2025HT Psicologia - Disturbi alimentari e sessualità: una visione lacaniana





